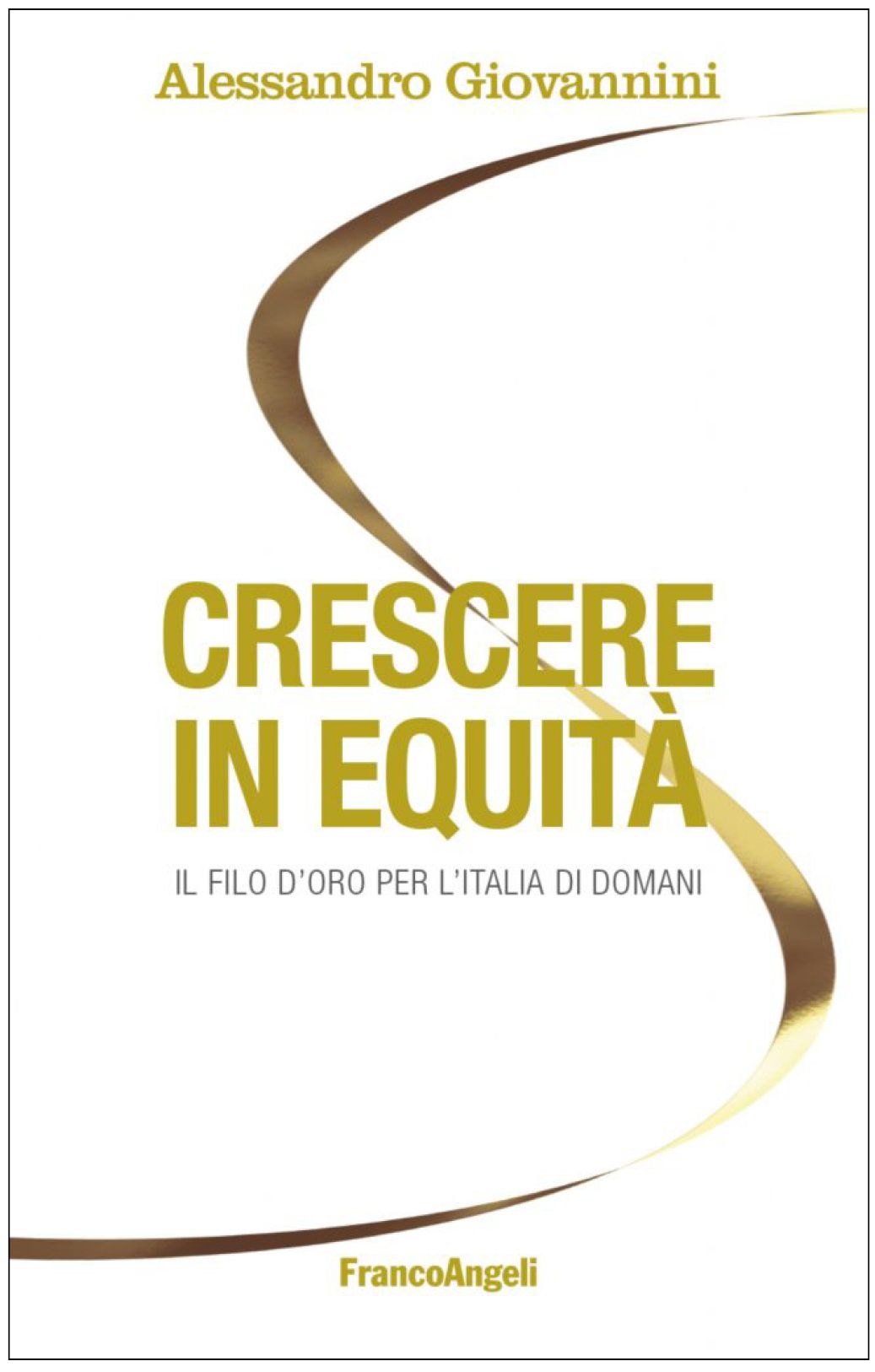Limitazioni alle libertà e ragionevolezza
Nel dedalo delle limitazioni e delle libertà: elementi per orientarsi e farsi un’idea in proprio.
È possibile che nel giro di qualche settimana il Parlamento o, in via d’urgenza, il Governo introduca l’obbligo vaccinale per fasce di popolazione sempre più ampie. Ed è possibile che fin d’ora estenda ulteriormente l’obbligo del green pass.
La situazione che si va profilando, quale che sia la prospettiva di analisi che s’intende privilegiare, è seria ed è un unicum. Anzitutto perché è la prima volta che Parlamento e Governo si devono confrontare con un ventaglio amplissimo di situazioni e interessi che mai, prima, si erano affacciati tutti insieme alla finestra della storia. Ogni provvedimento deve dialogare con diritti e doveri, obblighi e libertà, interessi collettivi e interessi privati, con economia e salute, scienza e buon senso, evidenze empiriche e supposizioni. E poi perché si deve confrontare con un sistema massmediatico non soltanto globale, ma anche accessibile a chiunque intenda farsi divulgatore attivo di notizie, vere o false che siano. Un sistema incontrollabile nei contenuti, ma potentissimo nel plasmare le coscienze, formare credenze, indurre in comportamenti anche contrari alle indicazioni delle autorità.
Nei limiti delle mie conoscenze vorrei provare a fornire qualche elemento di riflessione affinché ognuno possa dare una risposta in proprio alle domande centrali del dibattito: gli obblighi di cui si parla si possono considerare legittimi? E quali sono i criteri o i parametri da utilizzare per formarsi un’idea sulla legittimità o meno delle limitazioni, un’idea seria, costruttiva?

I presupposti dell’analisi: la funzione dei vaccini e la funzione della scienza. L’inutile “fumo” della discussione.
Fin d’ora sia chiara una cosa: non intendo proporre certezze, ma, come ho già detto, solo pochi, essenziali elementi di ragionamento.
Per mantenere questa promessa, sono necessarie alcune puntualizzazioni di metodo. La prima: assumo per presupposta la validità della teoria accreditata dalla comunità scientifica maggioritaria e validata secondo i criteri della scienza oggi vigenti, ossia che il vaccino sia lo strumento meno inidoneo a prevenire in misura ragguardevole la diffusione del virus, l’aggravarsi della sintomatologia nei pazienti infettati, i ricoveri ospedalieri e la morte degli infettati stessi.
La seconda: assumo che la scienza medica, come quella farmaceutica e quasi tutte le scienze dello scibile umano non siano infallibili, né possiedano verità assolute e immodificabili nel tempo. La scienza moderna non possiede verità, non ha per funzione quella di acquisire e proporre verità, men che meno eterne.
“Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato”, scrisse Albert Einstein nella lettera a Max Born nel dicembre del 1926 a proposito della teoria della relatività. La teoria popperiana sulla falsificazione, base della moderna metodologia scientifica, muove da qui, da questa frase, e a questa torna.
Oggi è pacifico che le proposizioni scientifiche non sono incondizionatamente vere o incondizionatamente false. E non lo sono perché non riproducono, né per intuizione, né per natura, una verità presupposta, assoluta, o una falsità presupposta, assoluta.
Le proposizioni scientifiche, piuttosto, sono proposizioni rigorose: non vere o false, ma rigorose o non rigorose, finalizzate al raggiungimento del risultato dotato di maggiore attendibilità tra quelli possibili in un dato momento e dunque di un risultato “falsificabile”, caratterizzato da un margine di fallibilità intrinseco.
La terza precisazione è questa: espungo da questa analisi considerazioni sia sull’origine della pandemia, sia sui motivi per i quali alcuni Stati, ad iniziare dalla Cina, e l’Organizzazione mondiale della sanità hanno inizialmente sottovalutato le conseguenze del virus su scala planetaria, sia ed infine, sugli interessi economici che ruotano intorno alla pandemia e ai vaccini.
Questi argomenti non li prendo in considerazione non perché irrilevanti, ma perché svierebbero la riflessione. Riflessione che, come ho detto, vuole semplicemente mettere in fila alcuni elementi di valutazione.
Affrontare “l’universo e dintorni” ripeterebbe l’errore ormai frequentissimo, almeno ai miei occhi, di accavallare i piani del ragionamento e creare un calderone fumante e sbuffante, così da offuscare, alla fine, con il fumo e con gli sbuffi, il cuore dei problemi e da appannare la mente dell’opinione pubblica.
Errore di metodo e di comunicazione, ma anche e principalmente errore intellettuale, proprio dei tempi moderni.

Green pass e obbligo vaccinale: i criteri di verifica delle limitazioni alle libertà.
Iniziamo col chiedersi se esista un dovere individuale di solidarietà sociale, linfa valoriale e giuridica dei successivi obblighi che in concreto possono limitare le libertà individuali. E col domandarsi quali siano i criteri utili per verificare la legittimità di tali limitazioni.
Il dovere di solidarietà sociale esiste ed esiste per Costituzione. Raramente è richiamato nel dibattito pubblico, eppure apre la nostra Carta, tanto è fondamentale. Lo stabilisce l’articolo 2: “La Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale”.
Questo dovere sta prima delle limitazioni alla circolazione, pure possibili per l’art. 16 della Costituzione, e prima dell’obbligo vaccinale, che il Parlamento potrebbe disporre in forza del secondo comma dell’art. 32 della stessa Costituzione. Imposizioni, sia chiaro, che devono o dovrebbero in ogni caso rispettare la dignità umana e i parametri di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà.
Il discorso si può ripetere per il green pass e per le altre misure via via introdotte. Ecco, allora, che cammin facendo abbiamo trovato la risposta anche al secondo interrogativo: sono ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà i criteri da utilizzare per verificare la legittimità delle limitazioni o dell’annullamento delle libertà individuali, indipendentemente dalle misure che concretizzano limitazioni o annullamento stessi.
Fra le diverse limitazioni – che siano quelle collegate al green pass o quelle collegate all’obbligo vaccinale non ha importanza per questo discorso – ciò che cambiano non sono i parametri di valutazione, ma l’intensità o la profondità delle limitazioni stesse e i presupposti di fatto sui quali si applicano quei parametri. Per esemplificare, un conto è valutare la ragionevolezza della riduzione della libertà determinata dall’obbligo di distanziamento, altro è verificare la ragionevolezza del suo annullamento associato all’obbligo vaccinale. Il parametro è lo stesso, la ragionevolezza, ma diverse sono profondità e tipologia di compressione, e diversi sono pure i presupposti di fatto che consentono di capire se quegli obblighi sono o non sono legittimi e quindi se quelle compressioni sono o non sono ragionevoli.
Il cuore della discussione sta tutto qui, nella ragionevolezza, ossia in un principio che, come scrive Marta Cartabia, è ormai “utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro”.
(considerata la finalità puramente divulgativa di queste riflessioni, la ragionevolezza è qui assunta come categoria di sintesi, archetipica di tutte le altre che ad essa in qualche modo si collegano e quindi anche l’uso del termine rispecchia questa preferenza espositiva).
Cos’è la “ragionevolezza” nelle limitazioni delle libertà individuali e nella tutela degli altri?
Cos’è la ragionevolezza, allora?

Senza tecnicismi e pretesa di completezza, si può anzitutto dire che cosa essa non sia: non è sinonimo di buon senso, non è criterio personale di comportamento, né designa saggezza, senno, sensatezza, non è un concetto filosofico e men che meno è un concetto morale. E non è neppure un concetto individuale, che ognuno se lo costruisce ad uso e consumo.
Ma se non è tutto questo, in cosa consiste? E’ un principio di diritto, arato e ampiamente spiegato dalla scienza giuridica, dalla Corte costituzionale, dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. E’ per prima cosa un criterio autolimitativo del potere statale, un criterio che delimita la “quantità” del potere stesso utilizzabile per raggiungere un fine pubblico con il minor sacrificio possibile dell’interesse dei privati.
Oltre a criterio limitativo del potere, è principio di qualità, che timbra qualitativamente una scelta legislativa, la quale, perciò, sarà legittima se ragionevole. Osando un paragone prosaico, la ragionevolezza è come la denominazione di origine controllata per particolari territori di coltivazione di vitigni o olivi. Nella Denominazione di Origine Controllata, la loro qualità e quella dei loro prodotti trovano il sigillo. E così la scelta normativa lo trova nella ragionevolezza.
Quali requisiti deve rispettare, dunque, per ottenere il sigillo? Semplificando molto si può dire che i principali sono questi:
- deve essere “idonea”, nel senso che il mezzo o lo strumento preferito dal legislatore deve essere congruo, adeguato al fine;
- deve essere “necessaria”, deve cioè cadere sul mezzo meno invasivo, su quello che, purché idoneo al fine, determina il sacrificio minore per i destinatari della legge, perché è proprio la maggiore mitezza dello strumento selezionato che comprova la necessarietà della scelta;
- deve essere “bilanciata”, frutto cioè di una comparazione di tutti gli interessi costituzionali messi in discussione. La scelta, in altre parole, deve seguire un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sent. n. 85 del 2013). Ma se le limitazioni all’autodeterminazione individuale si impongo per “esigenze di tutela della salute individuale e collettiva”, la prevalenza di queste esigenze può giustificare, di volta in volta, raccomandazioni od obblighi per i singoli a sottoporsi a specifici trattamenti sanitari. Trattamenti utili “non solo per migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche per preservare lo stato di salute degli altri” (sent. n. 5 del 2018 e prima n. 268 del 2017).
La valutazione probabilistica del maggior beneficio pubblico e del minore sacrificio privato.
Dal decisore politico non si possono pretendere scelte a “rischio zero”, perché impossibili già in natura, o decisioni prive di margini di incertezza, perché la mutevolezza del quadro epidemiologico e l’avanzare della ricerca rendono questi margini imponderabili, sfuggenti. Quel che si può e si deve pretendere è che decida osservando i criteri di “idoneità”, “necessarietà”, “proporzionalità” e “bilanciamento”, e che il suo decidere sia sorretto dalla prudenza, quale criterio guida dell’azione pubblica.

È un pò quel si chiede ad un guidatore di un mezzo pubblico. Così anche anche a chi guida la cosa pubblica si chiede di agire con prudenza, perché in gioco vi è la sicurezza di ognuno e di tutti.
Sebbene il decisore debba combinare tutti questi elementi e scrutinarli alla luce delle valutazioni scientifiche, le sue decisioni non condurranno mai a risultati dotati di infallibilità e neppure a risultati immodificabili, perenni.
Porteranno, piuttosto, alla composizione di scale probabilistiche di benefici e danni: a fronte di rischi pandemici validati dalla comunità scientifica maggioritaria, il Parlamento deve scegliere il mezzo di contenimento che comporti il minor sacrificio per il privato, ma anche il probabile minor danno per lui e per la collettività, perché solo in questo modo potrà assicurare il maggior beneficio per tutti. Probabilmente e temporaneamente.
Si ripete, tanto è importante: queste valutazioni non sono, e non potrebbero essere, sorrette dal crisma dell’infallibilità: gli eventi si compongono in scale probabilistiche ed è su queste che il decisore si muove nella scelta degli strumenti meno inidonei al fine. Eventi verosimili, probabili, appunto, e strumenti di prevenzione e contenimento del rischio reputati i meno inidonei nel momento dato, secondo criteri di validazione che in quel momento la maggioranza della comunità scientifica ritiene di dover privilegiare.
Nessuna certezza, nessuna infallibilità, nessun “rischio zero”, dunque, né per i singoli, né per la collettività.
Tuttavia, ed è aspetto altrettanto essenziale per una corretta valutazione del quadro normativo attuale, se la vaccinazione si dovesse rendere obbligatoria per l’aggravarsi delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche per come accertate dalle autorità mediche (sent. n. 268 del 2017 e n. 282 del 2002), a fronte di conseguenze dannose per il vaccinato – diverse da quelle normali e pertanto tollerabili – sullo Stato non può che ricadere l’obbligo di corrispondergli un’equa indennità (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).
Ora, concludendo su questi aspetti, se il «bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti è realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio di uno di essi in misura eccessiva», senza ragguardevoli motivazioni, e se la ponderazione «sulla proporzionalità dei mezzi rispetto alle esigenze da soddisfare» viola la regola del minor sacrificio per i suoi destinatari, le limitazioni alle libertà si devono ritenere illegittime, perché irragionevoli.
In caso contrario, le limitazioni alle libertà si devono considerare ragionevoli e perciò legittime (Corte cost., sent. n. 270/2005), sia che esse si concretizzino in vere e proprie imposizioni o restrizioni all’autodeterminazione sanitaria, sia che si traducano in strumenti di mera raccomandazione, sollecitazione o persuasione all’accettazione del trattamento sanitario.
Il decisore e i controllori: la “bollinatura” della ragionevolezza.
Chi decide? E chi controlla chi decide? Con questo gioco di parole, nel dibattito è entrato anche questo interrogativo. Vi è entrato con fare quasi di sfida. Se non ho male inteso, il senso della provocazione è questo. Si dice: chi decide che il vaccino sia lo strumento meno inidoneo a prevenire la diffusione del virus? E chi lo ha detto che la valutazione del decisore sia la migliore possibile? E se non lo è o non lo fosse, cosa si fa?
Insomma, il succo di questo tipo di ragionamento sta in questo postulato: nessuno si può sostituire alla volontà dell’individuo, perché solo a lui spettano, per una sorta di diritto naturale, le decisioni sulla sua sfera di libertà, intangibile, quella sfera e quella libertà, perché posta su un gradino superiore.
Questo modo di pensare è diffuso e non è nuovo. Si avvolge come un nastro alla storia degli ultimi decenni e riprende pulsioni ideologiche disseminate un pò in tutte le sfere dell’agire individuale e in quello politico. Smontare queste strutture di ragionamento è complesso e forse anche impossibile. Su di esse, comunque, tornerò alla fine.
Per ora quel che reputo opportuno fare è una cosa semplice, sebbene un po’ noiosa: ricordare per sommi capi come stanno le cose secondo la nostra Costituzione, così da riportare il discorso coi piedi per terra.
Qualsiasi comunità ha regole e organi deputati alle decisioni e nelle moderne democrazie sono previsti organi preposti a controllarne la legittimità, a “bollinarle” con il timbro della ragionevolezza.
Il sistema decisorio, da noi, ha come baricentro il Parlamento. Il Parlamento, è perfino banale dirlo, detiene il potere legislativo e dunque è il Parlamento che fa le leggi, a meno che esso stesso non deleghi il Governo ad emanare un decreto legislativo delegato (una legge sostanziale), fissando princìpi e regole generali, o a meno che non ricorrano motivi di necessità e urgenza. In questo caso, infatti, il procedimento si rovescia. A muoversi per primo è il Governo con un decreto legge e il Parlamento interviene solo in seconda battuta: nei sessanta giorni successivi può convertire il decreto in legge, modificarlo o non convertirlo.

Più complesso è il sistema di controllo. Il nostro ordinamento ha più filtri, via via sempre più penetranti. I primi sono rimessi ad alcuni organi parlamentari e in particolare alle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, che esaminano le questioni di costituzionalità ipotetiche prima che il Parlamento approvi la legge.
Vi è poi la Presidenza della Repubblica, che interviene dopo l’approvazione parlamentare, ma prima che il Capo dello Stato promulghi (firmi) la legge e la invii alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Infine, vi è l’esame della Corte Costituzionale, che entra in scena ex post, ossia quando una legge è già entrata in vigore e un giudice (civile, penale, amministrativo, sia esso un Tribunale o sia la Corte di cassazione) rimette la decisione sulla costituzionalità alla Corte stessa.
Anche le regioni e le province autonome possono impugnare una legge dello stato, ma solo se la ritengono lesiva delle proprie prerogative, se ritengono, cioè, che intervenga su materie loro riservate.
Dopo l’entrata in vigore della legge possono essere chiamate a decidere anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea e, come organo di diritto internazionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo.
V’è poi un sistema, così detto, di controllo diffuso, che lo possono esercitare tutti i giudici (da quelli di pace alla Corte di Cassazione) durante un processo che si svolge innanzi a loro.
È un tipo di controllo creato dalla Corte costituzionale nel corso dei suoi settant’anni di attività. Si tratta di una verifica interpretativa: il giudice, se la legge da applicare è di dubbia legittimità, prima di rimetterla alla Corte Costituzionale deve provare ad interpretarla in modo da renderla conforme ai princìpi della Costituzione. Si chiama, tecnicamente, “interpretazione costituzionalmente orientata”.
Le leggi, infatti, ha affermato in più occasioni la Corte, non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile dare di esse interpretazioni incostituzionali, ma solo perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali.
Questo è il quadro degli organi decisori e controllori.
Si dirà: e il popolo cosa può fare? Cosa può fare direttamente?
Ad esso – e solo ad esso – spetta la sovranità, che deve però esercitare nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione.
Ecco, allora, che ad esso la Carta riserva, da un lato, il diritto di voto politico e quello referendario; da un altro, il diritto di raccogliere le firme per leggi di iniziativa popolare; da un altro lato ancora, il diritto di opporsi alle decisioni del Governo o alle leggi del Parlamento manifestando liberamente il dissenso, scendendo in piazza o nei modi ulteriori di esternazione del pensiero, oppure veicolando il dissenso stesso tramite i partiti e le forze sociali, i singoli parlamentari rappresentanti del territorio, le comunità di appartenenza, le associazioni e via dicendo.
Poco, troppo poco? Può darsi, ma ad oggi è previsto questo. Non mischiamo ulteriori argomenti a quello già complesso del quale stiamo parlando. Il rischio è quello, come già detto, di finire in un dedalo di temi e problemi, senza riuscire a venire a capo di nessuno di essi. “L’universo e dintorni” qui non interessa.
La democrazia rappresentativa, la comunità e lo “sfregamento” delle libertà.
Ho promesso all’inizio che mi sarei limitato ad offrire pochi, essenziali elementi di riflessione, senza pretesa di spargere al vento semi di verità o cose di questo genere. Spero di aver mantenuto fede all’impegno.
Una riflessione finale, però, mi sia consentita, che riguarda non soltanto la questione vaccinale e le diverse forme limitative delle libertà individuali, ma anche la concezione di democrazia rappresentativa e il senso di comunità che si sono “formati” o “sformati” in questi ultimi decenni.
Il dissenso verso qualsiasi forma di limitazione alle libertà si radica, forse inconsapevolmente, su un’idea di stato, di democrazia e di collettività organizzata che provo a riassumere in questi termini: la collettività non è un bene da proteggere in quanto tale, ma è soltanto un feticcio costruito a bella posta per garantire i detentori del potere e consentire loro di manipolare le masse per lucrare sui loro bisogni, largamente indotti, però, con tecniche di persuasione, se non addirittura di plagio, tecniche che finiscono per immettere nelle loro menti paure e nemici. La malattia, la morte e il virus, ancor prima che realtà oggettive, sono fantasmi ingigantiti dalla narrazione perché la loro vera corporalità è assai minore di quella sbandierata, facilmente gestibile in modi diversi da quelli scelti dall’autorità.
Lo Stato, di conseguenza, diviene esso stesso partecipe di questo “complotto” e gli strumenti che propone come protettivi del bene generale non sono in realtà tali. Sono essi stessi strumenti di plagio, strumenti della macchinazione ordita ai danni di miliardi di soggetti e intere nazioni. Dunque, qualsiasi strumento che limiti le libertà va respinto e combattuto.
Con la conseguenza ulteriore che anche il modello di Stato costruito sulla democrazia rappresentativa, quella parlamentare, com’è la nostra, si trasforma in feticcio da sostituire prontamente con un modello – peraltro non meglio precisato, se non con slogan privi di sostanza – che privilegi la diretta volontà del singolo.
Ed ecco rinascere, alla fine, il mito della libertà, intesa come autodeterminazione individuale, indipendente da tutto e da tutti. Come Ecate, dea delle scelte e della libertà di scelta, fu adorata dagli antichi greci, così l’autodeterminazione è la nuova dea adorata dai contemporanei.

In questa veloce esposizione ho forse estremizzato le argomentazioni, ma penso che il succo dei ragionamenti di chi si fa paladino dell’autodeterminazione senza limiti sia più o meno questo.
La riflessione che mi sono proposto di fare, allora, si riduce a queste poche e asciutte parole.
Che lo Stato e la collettività siano ipostatizzazioni di concetti irreali è fuor di dubbio. Sono contenitori elevati per finzione ad entità autonome, distinte dagli individui, poiché storicamente reputate le più adeguate o le meno inadeguate a garantire la convivenza e l’ordine, la gestione delle finanze e gli eserciti, e via dicendo. E non v’è dubbio neppure che l’intera catena di regole e organi possa risentire, nelle scelte, di condizionamenti esterni, magari alimentati dal sacro fuoco del profitto o magari da quello altrettanto sacro del controllo delle coscienze e dei comportamenti degli individui.
Detto tutto questo, rimangono però due evidenze empiriche. La prima: il libero arbitrio, portato dal privato al pubblico e moltiplicato per milioni o miliardi di individui, sfocia giocoforza in forme di anarchia o addirittura di caos. Il libero arbitrio, dunque, se nel privato diventa autodeterminazione individuale, come tale incomprimibile in uno stato laico e liberale, nel sociale non può che essere regolamentato. Pena, appunto, il caos.
La seconda evidenza è questa. Alcuni beni – la vita, la salute – che pure sono di “proprietà” esclusiva dell’individuo, nel sociale perdono questa dimensione di esclusività. E la perdono perché interagiscono con beni di identica natura appartenenti ad altri individui. In questo “sfregamento”continuo sta il limite all’esclusività della gestione del bene stesso.
Il bene è e rimane individuale, ma non può che essere gestito anche nell’interesse di chi dallo “sfregamento” può subire conseguenze dannose. E’ la gestione del bene che non può essere rimessa soltanto all’autodeterminazione individuale. E’ lo “sfregamento”, insomma, la chiave di tutto.

Alessandro Giovannini
Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di Siena
Avvocato, Commercialista e Revisore dei Conti
I temi del blog
Le ultime pubblicazioni
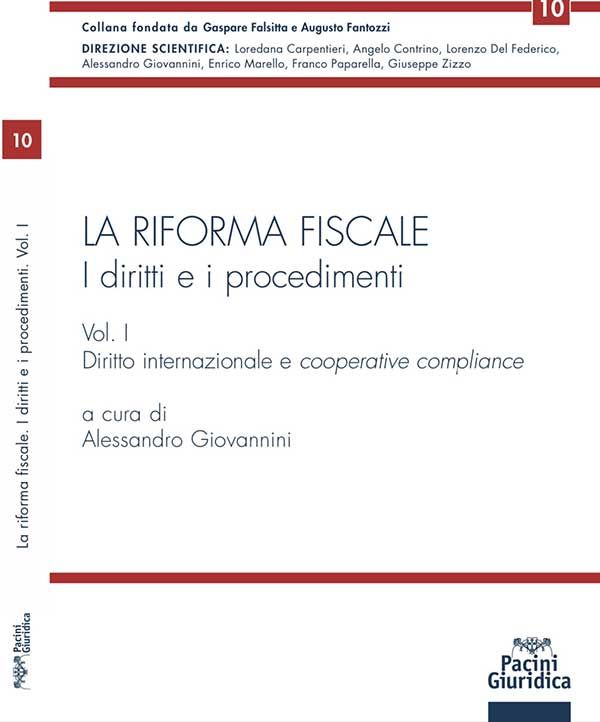
La riforma fiscale – I diritti e i procedimenti
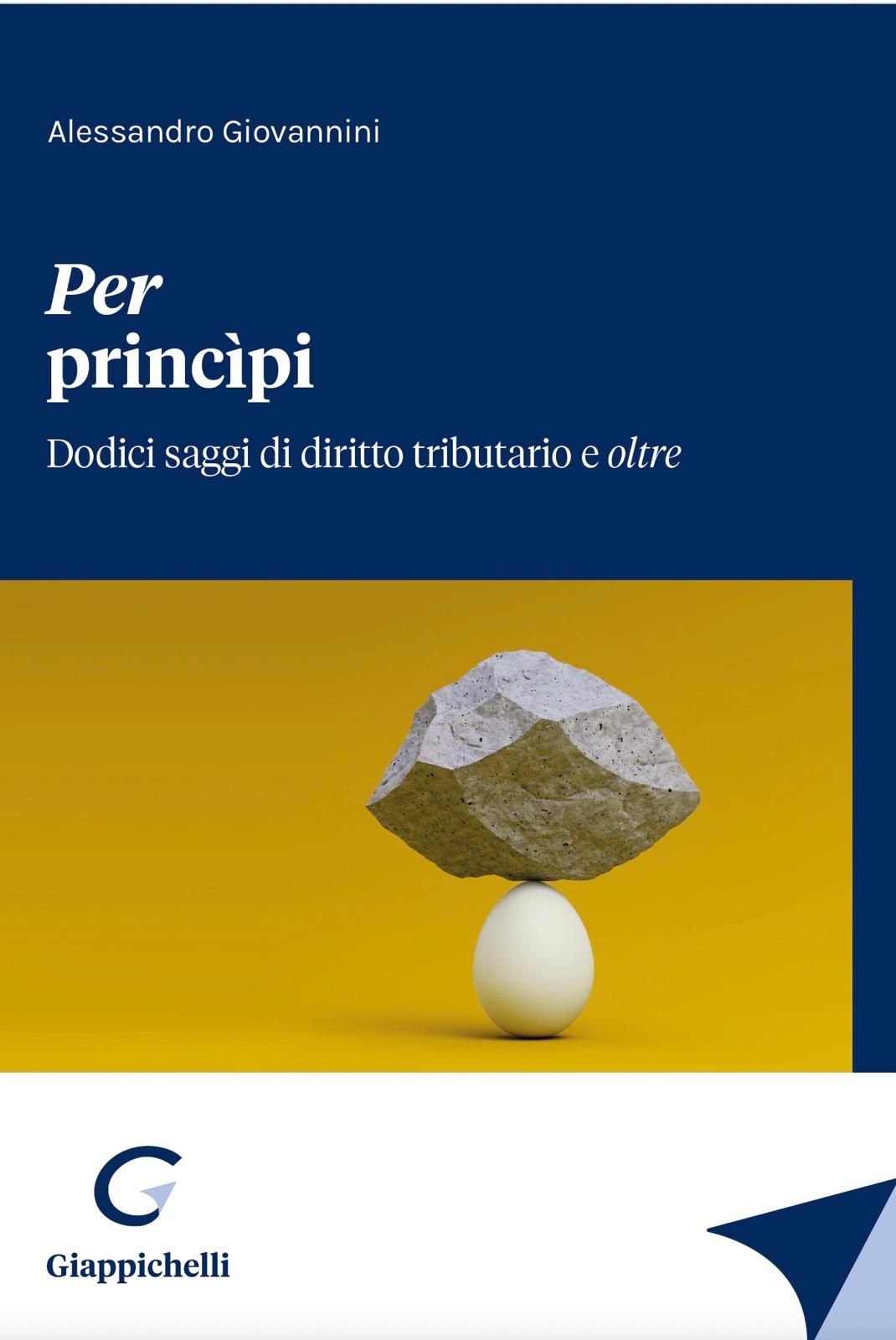
Per princìpi